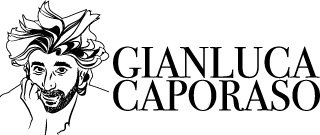Mia amata,
si racconta solo il dimenticabile. Perché ciò che nasce per durare, basta solo nominarlo. È qualcosa di tutti. Un labirinto in cui ci abbandona la memoria.
Chi si racconta si cura, mia amata. Le parole servono a questo. Alcol, ovatta, cemento per riparare la pelle vecchia delle fondamenta e mettere un mattone al posto di un polmone ferito.
Il resto affiora sulla bocca della pagina, avanzo, versamento, germoglio o bolla che non ne possono più di viscere e interiora, e vogliono durare nella luce, fosse pure quella di una stagione sola, come i fiori.
E così parliamo, mia amata. È sera e nelle mie parole si accende la città, la città si addormenta con un occhio solo, come i giganti. L’altro resta aperto a elettrica tutela degli innamorati, dei nottambuli, dei fornai come il papà di Rodari.
La città semina scarpine deliziose nelle strade più nascoste, nella condensa degli abitacoli, per i portici pisciosi. Le lascia in pegno agli innamorati, perché le facciano durare oltre la notte e calzare anche nel batticuore del giorno dopo.
Mi accompagna, in questa notturna evanescenza, la gonna in plastica di una vecchia lampada che fa della sua luminescenza la ronda alle mie pagine, mentre io, guardia giurata dei pensieri, sto lì con la penna ad aspettare di pescare parole che nuotano nella corrente.
Nelle mie parole, mia amata, si accende la città, la città si addormenta e io la guardo come le cose che si guardano fino al punto di perderle di vista.
Così, alla fine delle forme consuete, le finestre illuminate si fanno crune in cui far passare il filo dei desideri e cucire una pace a ogni vita ancora sveglia, per tutti coloro che avrebbero voluto vedere un arcobaleno di profilo e impararono soltanto come disfarne l’intreccio; le finestre si fanno fari per i baci ancora in viaggio, ancora in giro verso il traguardo di bocche che li cercano come la pioggia nella pioggia, come le mani nelle mani, allo scopo ultimo di non sapere più dove finisce l’uno e comincia il tutto, il noi.
D’improvviso la città sorride, come chi sogna felice qualcosa che sarebbe bello portare anche nell’aldiquà.
E io la percorro nelle sue vene di pietra dove il tempo trova sempre una piega, un taglio, una fessura in cui nascondersi per essere trovato soltanto da chi sa; o un mattone saltato nel quale inciampare nella sera dei ricordi, quando nomi, visi, persone sembreranno troppo lontani per uscire da lì sotto, dove pure un tempo si erano avverati.
Intanto vago come una moneta, anonimo e senza portone alcuno da chiamare casa.
Vago per la città che dorme alla punta della mia penna come un equilibrista sopra i fili delle parole, come uno
zingaro impiegato a tempo determinato per redigere l’inventario dei sussurri, delle ombre, di tutte le cose indicibili che la città, fossero pure macerie, deve confidare al cielo che da sempre la protegge e la minaccia, secondo i capricci delle stelle o dei temporali.
Mentre vago, mia amata, tiro fuori il fazzoletto che ho sventolato da dietro le finestre, nei vecchi terminal, nelle stazioni o per le strade, quando qualcuno è andato via e sono tornato solo, e dentro trovo il vento che continua a dire quei nomi.
Forse le parole sono questo, mia amata, un vento rannicchiato nelle cose, specialiste delle partenze.
Un vento che sa parlare, che tira fuori il nome giusto quando meno ce lo aspettiamo, come la pipì dei bambini, che non sai mai quando scappa.
Proseguo, mia amata.
Al termine delle mie parole cadrà una stella e un bambino venuto fuori dal buio con un mucchio di lune nella mano, la raccoglierà.
Quel bambino è l’esito delle mie parole.
Mi è costato tre insonnie e due poeti, un raduno di polvere sopra la gonna in plastica di una vecchia lampada e la pioggia, l’odore della pioggia.
Quel bambino avanza e mi accorgo che ha una luna nelle scarpe. Cammina e semina grani d’argento.
I suoi passi mi sembrano passi in cui ho già camminato. E i suoi segni sono parole d’argento che mi hanno segnato da sempre.
Poi, al termine delle parole ritrovo il bianco della pagina che si riprende quelle che non sono arrivate, quelle che non hanno abboccato. Il bianco le rimbocca e le custodisce sotto le righe, le chiude nelle scatole come giochi di infanzia.
Ora mi addormento, mia amata e la città, spente le parole e acceso un bambino con la luna nelle scarpe, diventa muta. Per provare se ancora respira, con l’ultimo pensiero che mi resta aiuto il cielo ad abbassarsi, farsi vicino, avvicinare l’orecchio per sentire.
Si! La città respira ancora. Sotto brulicano parole notturne. Cadono direttamente negli ascolti celesti.
Forse è per questo motivo, mia amata, che certe cose si dicono di sera e i poeti e gli innamorati cantano di notte: hanno il cielo a portata di bocca: possono volare.
A presto, mia amata.
Potenza, Circolo Gocce d’Autore – 23/11/2019